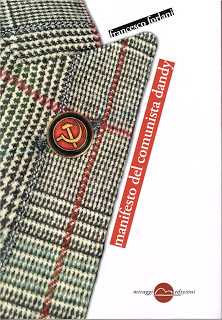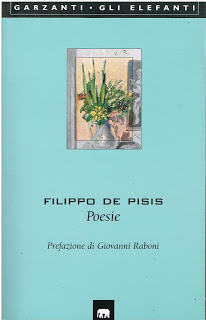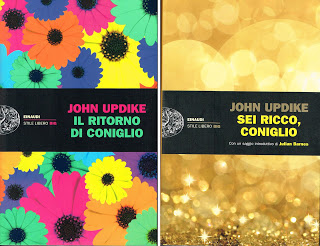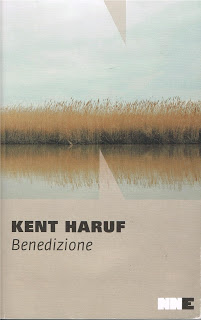DAVIDE VARGAS AUGUST LIST
Un'altra piccola lista di fine estate grazie a Davide Vargas per le sue suggestioni.
Francesco Forlani
Manifesto del comunista dandy
Miraggi edizioni 2015
Manifesto del comunista dandy è lo specchio del suo autore. Brillante. Irridente. Caustico. Confusionario (gli articoli sono numerati praticamente come capita). Pieno di sovrapposizioni e di deviazioni. Divertente. Intelligente (che per me è la qualità più significativa). Riconoscente ai propri personalissimi riferimenti (che sono di ogni genere). Elegante (avete mai visto come si veste Francesco?). Coinvolgente (tant’è che sto scrivendo inserendo incisi e parentesi come non ho mai fatto).
Eppure. Come già in Parigi senza passare dal via (quando parla della sua famiglia) ci sono dei tratti, una frase o anche una parola o una sola immagine, che per me lettore sono dei pugni nello stomaco. Scarti dell’andamento lieve che sottende il libro. E sono pezzi dove avanza la bellezza della scrittura. Un tono struggente. Una specie di malinconia languida dove perdersi è dolce. Insomma, la sua poesia. Come: “Ho pensato a certe notti di asfalto e cenere, di strade che si bruciano da sole perché veloci anche per un corridore esperto - ma dei binari morti amo la vita che la ruggine rievoca con l’arrivo della locomotiva.”. Bello, no?
Filippo de Pisis
Poesie
Garzanti 2014
Sono sempre molto attratto dagli artisti che frequentano linguaggi diversi. Nel novecento ci sono stati molti artisti/poeti. Da Scipione a Melotti a Scialoja. E anche poeti/artisti. Montale o Pasolini.
Filippo De Pisis nasce alla fine dell’ottocento e opera in pieno novecento. Le sue pitture sono note. Ma non conoscevo le sue poesie. Le ho lette. Hanno una forza autonome. Vale a dire: è ininfluente conoscere il lavoro pittorico di De Pisis. Ci sono le poesie e basta. Che sono limpide (stavo per dire come i suoi quadri ma me lo rimangio).
È l’altro novecento. Quello che non abbraccia l’ermetismo. Ma resiste a costruire immagini di cristallina chiarezza. Una precisione dell’immagine e del sentimento che ti fa tremare. Una specie di lirismo struggente che a leggerlo ti invita a sciogliere i legacci e a nuotare in una sorta di acqua pulita. A me è capitato questo.
La poesia fa di questi miracoli. Anche se parla di ortiche (In un angolo sterposo/fra ferri rossi di ruggine, barattoli e immondizie/le vecchie ortiche isteriche,/). O di semplici campanelle (Nel verde folto contro il vecchio muro/sono comparse stamane d’un tratto/delle dolci bianche campanelle/). O di foglie secche (Cadono le foglie gialle dal fico/e dal mio cuore partono/vaghi sogni).
Mi viene da pensare che nel tanto bistrattato lirismo ci sia più sperimentazione che altrove.
TEX
Tempesta su Galveston
Sergio Bonelli Editore
Il Texone esce una volta all’anno. Da trenta anni. Ognuno con uno sceneggiatore e disegnatore diverso. Gente che magari non ha mai disegnato un cavallo che si confronta con praterie e scazzottate. Sempre molto bello. A me è sempre piaciuto rintracciare lo stile. E anche carpire certi dettagli, come disegnare un ciuffo d’erba. O le rocce. O le nuvole in cielo.
Tempesta su Galveston porta già nel titolo la ragione della sua grandezza. Galveston è un romanzo di Nic Pizzolatto (ne ho già parlato qui). E Nic Pizzolatto è l’autore di True Detective. Il cerchio si chiude.
La storia si rifa per certi versi al Django di Quentin Tarantino. Un gigante schiavista è il cattivo di turno. Intorno a lui un giudice corrotto, una banda di assassini e la bella proprietaria del saloon. E come il “mio nome è Bond, James Bond” (altra icona) ci sono i marchi di fabbrica di Tex. Uno su tutti. I due pards arrivano a Galveston e si avviano a mangiare una bistecca…”a noi piace alta tre dita….e ben cotta….magari scortata da un esercito di patatine…e mi raccomando amigo, non scordarti la birra gelata…”
La storia si conclude sotto la pioggia. Tra le paludi (come in True Detective). Mi sembra un gran pezzo di bravure disegnare 40/50 pagine di azione sotto la pioggia prima e la tempesta dopo. È la cosa che più mi è piaciuta. L’acqua scorre sulle falde dei cappelli. Sgocciola dalle pistole e dai capelli. Schizza dalle pozze calpestate dagli stivali con gli speroni. Marcisce le impalcature dei ponti e delle baracche. Affonda i tronchi degli alberi. Poi la tempesta. Rabbuia il cielo. L’uragano scoperchia le case. Solleva onde gigantesche. Insegue e travolge uomini e cavalli.
E si placa quando giustizia è fatta (quella elementare di Tex, ma non fatevi ingannare. Tex è stato uno dei primi amici degli indiani. Un progressista insomma)
John Updike
La saga di Coniglio
Einaudi
John Updike è un gigante della letteratura. In assoluto, non solo americana. Anni fa avevo trovato un suo libro su una bancarella. S, il titolo. Una roba epistolare. Non mi era piaciuto e mi sono portato dietro questa idea negativa fino a ieri, praticamente. Einaudi sta ristampando la saga di Coniglio. Senza seguire un ordine cronologico. Prima Sei ricco, Coniglio e poi Il ritorno di Coniglio. Ne usciranno altri due. Harry Angstrom si porta addosso il soprannome di Coniglio. Alle spalle ha un grande passato di promessa del basket (Corri, Coniglio, non ancora ristampato). Ed è un irriducibile e inevitabilmente americano medio. Ma direi uomo medio. Come tanti di noi. Siamo alla fine degli anni settanta. Tra Vietnam e crisi economica. Una moglie, Janice e un figlio, Nelson. Ognuno in qualche modo si fa una ragione della presenza degli altri due nella propria vita. Attraverso allontanamenti e ritorni. Comprensioni e accapigliamenti. Poi c’è una folla di personaggi al contorno. E soprattutto ci sono tutte le utopie e i sogni degli uomini quando si fottono. Ma su tutto, il tono di un uomo (e di una donna perché Janice è un personaggio altrettanto potente) che come le canne al vento si piega continuamente ma non si spezza mai. E vive questa condizione di perdente con lo spirito dei pionieri americani: niente è irreparabile. Così viene fuori una figura (e dei dialoghi, che sono la cosa più bella dei libri) che ha un nocciolo di dignità, piccolo e sotterrato certo, ma sempre riconoscibile. Legandosi al quale si può attraversare le fasi di un’esistenza con l’ironia lieve di chi non ha grandi scopi se non stare a vedere che succede.
Kent Haruf
Benedizione
NNE
Questo è un grande libro. Kent Haruf va a braccetto con Cormac McCarthy e Richard Ford. Per dire a che livello scrive. Da Dio, insomma.
Dad Lewis è una figura rispettata nella piccola città di Holt. E sta morendo. La moglie e la figlia gli sono vicini. Gli amici vanno e vengono dalla sua casa. Una bambina va in bicicletta sotto il suo sguardo dalla finestra vicina. Il reverendo predica e passa a trovarlo.
Ma ognuno ha un qualche fantasma con cui fare i conti. Dad per primo. Il figlio omosessuale è andato via di casa e non da sue notizie. Il suo commesso (Dad ha un negozio di ferramenta) si è ucciso dopo che lui lo ha beccato a rubare.
Sono le relazioni umane. Le scelte estreme. Il coraggio e il non coraggio. E la vergogna. Dad non è l’unico che deve fare i conti con tutto questo. È come se in questa cittadina (così simile alle nostre realtà provinciali) l’attitudine ad ignorare ogni difformità rispetto all’onda del perbenismo comune fosse arrivato il momento della resa dei conti. Niente può essere più sottaciuto. Ma la voce di Kent Haruf è sempre bisbigliata. Per questo non ha bisogno di molte parole. La narrazione va avanti per immagini scabre. Dialoghi secchi. Scarnificati. I sentimenti sono elementari. Perciò solidi e senza retropensieri. Le tragedie sono solo evocate. E non c’è bisogno che accadano fatti eclatanti (quando la bambina si allontana in bicicletta e non si trova più ti aspetti il peggio e invece riappare). È sufficiente la quotidianità.
Tutto molto vicino alla poesia.