L'EMPATIA DEGLI SPAZI
Non so perchè leggendo questo breve testo di Valerio Mosco ho pensato alla Endless House di Frederic Kiesler.
Per Kiesler, il principio fondamentale della costruzione dello spazio non è legato alla forma dell'abitare quanto alla forma del vivere mantenendo sempre intatto quel rapporto essenziale tra uomo e natura.
Una concezione che prefigura uno spazio che prende forma dentro di noi attraverso dei principi spaziali che sono coltivati nella nostra memoria e definiti attraverso una costante verifica immaginativa, nessun tentativo di standardizzazione, e riproduzione tecnica, ma la semplificazione di un' esigenza interiore.
La casa non è una macchina, ne la macchina un'opera d'arte. La casa è un organismo vivente e non solo un assemblaggio di materiali morti… La casa è un epidermide del corpo umano. Il desiderio di semplicità non deve sfociare nel impoverimento della (casa/case minime) ma è una concentrazione di tutti i mezzi in grado di rispondere ai bisogni vitali di una o più persone…Essa deve contribuire ai bisogni interiori dell'uomo...non possiamo confidare ne nel paradiso industriale ne nella scienza di un solo architetto...abitare è un bisogno eternamente immediato e pressante....
Una Divagazione la mia, ma anche la necessità di trasformare i movimenti del corpo nel movimento dei nostri pensieri.
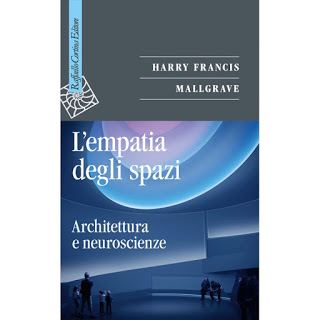
Harry F. Mallgrave;
L’empatia degli spazi. Architettura e neuroscienze
Raffaello Cortina, 2015
di Valerio Paolo Mosco
di Valerio Paolo Mosco
Scrive nel suo libro L’empatia degli spazi. Architettura e neuroscienze Harry Francis Mallgrave: “il fatto che percepiamo (e quindi concepiamo) l’ambiente costruito tramite l’intero nostro corpo può sembrare una cosa del tutto ovvia, ma per formazione gli architetti tendono a pensare gli edifici come a oggetti astratti o composizioni formali che esistono in uno spazio geometrico libero, piuttosto che come luoghi esistenziali della nostra conoscenza tattile”. Percepire con l’intero nostro corpo, in definitiva essere il nostro corpo in relazione all’ambiente costruito. A riguardo un po’ di filosofia spiccia non guasta. Il razionalismo nasce con Cartesio, dal suo cogito ergo sum, messo in crisi, o meglio ampliato da Kant e Schopenhauer e dopo di loro da Heidegger, basti ricordare il suo dasein, quell’essere nel mondo in maniera che oggi potremmo definire olistica, come conoscenza incarnata. Gran parte dell’architettura degli ultimi decenni sembra essersi dimenticata di ciò. Ha prevalso infatti il concettualismo cartesiano e con esso, inevitabilmente, l’intellettualismo. Oggi (e sta qui l’attualità del libro di Mallgrave) nel declino del concettualismo risuona più forte che prima il grido di Zarathustra: “io sono il mio corpo, null’altro che il mio corpo”. Il bel libro di Harry Mallgrave (per chi non lo conoscesse uno dei più illustri storici dell’architettura statunitensi) intende essere una risposta all’appello di Zarathustra attraverso una scoperta della fisiologia scientifica degli ultimi anni, quella dei neuroni a specchio. La scoperta è stata fatta a Parma da un gruppo di scienziati italiani negli anni ’90 che oggi fanno riferimento a Vittorio Gallese, autore tra l’altro dell’introduzione al libro di Mallgrave. Studiando il comportamento degli scimpanzé gli scienziati italiani hanno scoperto che la conoscenza di questi animali procede per empatia. Se infatti uno scimpanzé vede un altro scimpanzé mangiare una banana da un suo simile egli attiva gli stessi neuroni che attiverebbe se mangiasse lui stesso la banana. La stessa empatia neuronale si attiva nei confronti delle cose inanimate, negli scimpanzé come negli uomini e ciò specialmente per quel che riguarda l’architettura. Scrive Gallese nella prefazione: “Guardare un edificio, una stanza oppure un oggetto di design significa anche simulare i movimenti e le azioni che quegli spazi e oggetti evocano”. Questo processo viene chiamato dagli scienziati embodied simulation, simulazione incarnata, un processo che come negli scimpanzé avviene in modo precognitivo. Personalmente mi è capitato di rendermi conto di ciò all’interno del Redentore di Palladio. La luce diafana ed equipotenziale che cosparge le pareti del Redentore, il suo nitore astratto capace di rivestire quelle pareti di un manto lunare produce un effetto comportamentale su coloro che la visitano che sentono questo manto, la sua presenza intangibile, e con essa la sua aura e allora si tengono al centro della navata, discosti dalle pareti, in una sorta di soggezione che è poi quella di chi si trova di fronte al mistero paradossale del nitore assoluto. Se invece entriamo in una chiesa romanica, l’effetto è di tutt’altro genere. Noteremo infatti che chi entra si tiene ben attaccato alle pareti come se volesse essere scortato nelle cupe cavità tipiche dello spazio romanico. Stupisce che comportamenti di questo genere, tangibili e corporei, siano stati ben poco indagati dalla storiografia e dalla critica ufficiale di fatto del tutto concentrata invece sul valore intellettuale dell’opera, sulla sua presenza celebrale. Eppure la storiografia moderna non è nata sotto la stella dell’intellettualismo. Pensiamo alle teorie dell’Einfhülung e della Gestalt a cui Mallgrave si rifà; teorie che, basta leggere Wölfflin, hanno posto la reazione fisiologica e psicologica alla base del fenomeno artistico, specialmente di quello architettonico fino al punto di considerare la stessa architettura come corpo che racchiude al suo interno altri corpi. L’effetto di tutto ciò è stata ad esempio la scoperta di quello spazio interno che Schmarsow consegna a Zevi. La tesi di Mallgrave è così riassumibile: le intuizioni dell’Einfhülung possono oggi essere dimostrate scientificamente con le scoperte delle neuroscienze e così possono finalmente trovare una oggettività tale da convalidare la tesi che la bellezza non sia soltanto come voleva Kant una per altro mistica inferenza tra sensazione ed intelletto, ma che sia un senso aggiunto, senza il quale il mondo rimarrebbe muto. Non è un caso quindi che Mallgrave citi all’inizio del suo lavoro il magnifico libro sulla bellezza di Roger Scruton, che da tempo rivendica le ragioni dell’homo aesteticus rispetto a quello intellettuale. D’altronde la tesi di Mallgrave è convalidata dal fatto che, come dice Kundera, il dissenso estetico è il più violento, è di pancia, mentre quello intellettuale, meno viscerale e meno incarnato nel nostro corpo, è sempre mediabile, anzi di sua natura è predisposto a scendere a compromessi. Personalmente non sono particolarmente interessato alla scientificità neurologica dell’estetica, che poi è il vero soggetto del libro di Mallgrave. Penso infatti che come nei sentimenti, siano più importante gli effetti delle cause e anzi mi spaventa in parte la spiegazione fisiologica che come tale ha sempre qualcosa di riduttivo e deterministico. Sono invece interessato alle conseguenze del messaggio di Mallgrave, al suo attacco coraggioso nei confronti di un intellettualismo sempre più arido, nei confronti della sociologia a buon mercato con cui si vende nel mercato accademico l’esperienza estetica. Così sono attratto verso il suo spendersi per le ragioni dell’estetica, per l’autonomia disciplinare della stessa e sono d’accordo con Mallgrave sul fatto che “l’architettura sia primariamente un’esperienza incarnata”. Mi ritrovo poi completamente in un’altra frase di Mallgrave: “(la bellezza) è semplicemente una parte integrante del nostro modo di entrare in contatto con le cose intorno a noi e di animarle, di esprimere la nostra vitalità e il nostro senso di essere vivi”. Una frase del genere fino a poco tempo fa avrebbe suscitato anatemi e processi accademici. Seguaci da cortile di Deleuze, ruminatori delle sulfuree inconsistenze che si dovrebbero trovare tra le parole e le cose, impresari a cottimo del bene comune, concettualizzatori di mai chiariti concetti, materialisti orgogliosi della loro aridità e esegeti del brutto di massa si sarebbero scagliati contro lo stesso utilizzo della termine tabù degli ultimi decenni: contro la bellezza. Mallgrave, come Scruton, come Zeki, come Pallasmaa e altri ancora, ci incoraggia a combattere la battaglia delle ragioni del bello. Una guerra appena iniziata che non ammette comportamenti ignavi, che necessita di una presa di posizione da parte di tutti noi. Personalmente consiglio di trasferirsi in montagna e da partigiani combattere contro la violenza dei regimi culturali da troppo tempo dominanti. E’ il momento di abbatterli: la loro inconsistenza è evidente.