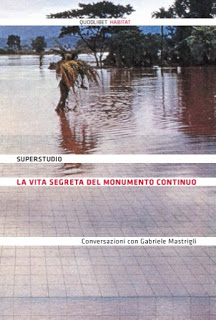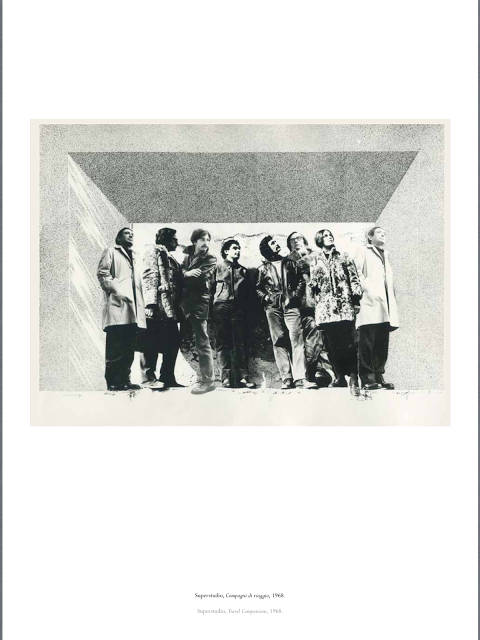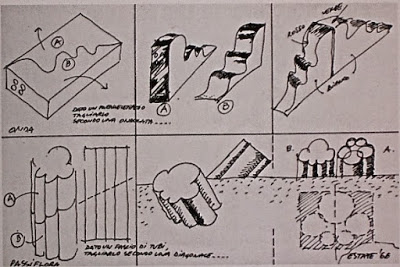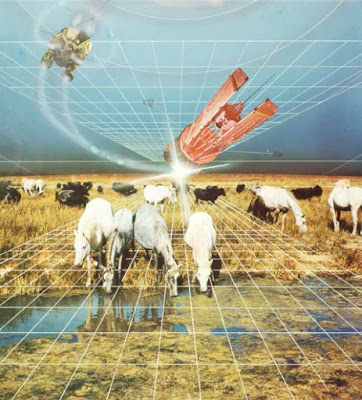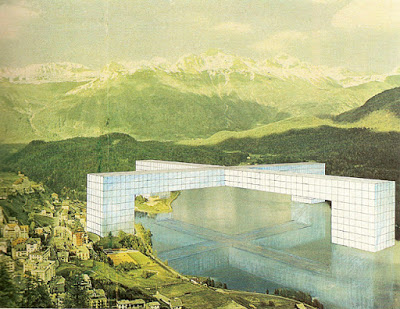LA VITA SEGRETA
Giovedì 15 ottobre la galleria Campo ha cominciato la serie di dialoghi d'architettura che hanno i libri come protagonisti, l'autore Gabriele Mastrigli ha raccontato la lenta costruzione del suo che raccoglie le parole dei Superstudio.
L'inizio della storia inevitabilmente comincia da un viaggio nella memoria che Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia e Piero Frassinelli intraprendono in parallelo, mostrandoci linee comuni ma anche disaccordi, rendendo evidente come il lavoro di un gruppo non è mai fatto di singolarità ma di un procedere lento, in cui ognuno aggiunge qualcosa all'idea dell'altro, un confronto dialettico, andare avanti per poi tornare indietro senza mai perdere la voglia di costruire un progetto comune.
Ogni voce narrante non conosce le parole dell'altra, le scopre così come farà il lettore dopo.
I Superstudio hanno avuto la forza di chiuderlo questo viaggio, nel momento in cui sentivano che forse era necessario procedere ognuno per conto proprio, senza perdere comunque interesse verso l'architettura che dopo la fine ha preso direzioni diverse, come le loro vite. Oggi si ritrovano di fronte a tante finestre aperte sul futuro, perchè alla fine non si sono ancora stancati di guardare al loro passato trascorso insieme.
Altri autori si incontreranno nello spazio Campo a Roma per parlare di libri, vi terremo aggiornati http://www.campo.space/about/ .
Superstudio
La vita segreta del Monumento continuo
a cura di Gabriele Mastrigli
Quodlibet 2015
Forse il modo migliore di conoscere una storia è di ascoltarla attraverso la
voce dei suoi protagonisti, la storia del Superstudio prende forma attraverso
le parole dei tre architetti che più
degli altri hanno contribuito alla formazione di un pensiero che prende
forma dalla realtà piuttosto
che da un’utopia astratta.
Gabriele Mastrigli lo racconta molto bene nella sua introduzione
al volume, gli aspetti più importanti
del lavoro del gruppo Radicale fiorentino riguardano due componenti essenziali
del fare architettura e che oggi sono molto importanti per chi concepisce
l'architettura come una forma di pensiero, qualcosa che va oltre alla pratica
del costruire.
Da un lato l'invenzione narrativa come vera e propria prassi
progettuale; dall'altro la critica sprezzante al ruolo dell'architettura nella
società contemporanea,
sino alla messa in discussione dei suoi stessi fondamenti - dell'architettura e
attraverso di essa della società.
I discorsi per immagini
costruiscono prima di tutto un immaginario attraverso il quale prefigurare un
sistema di vita, che nel corso degli anni prende forma anticipando situazione molto evidenti
nell'architettura contemporanea.
Questo tipo di narrazione è
da una parte metodo, dall'altra necessità
espressiva di considerare l'architettura qualcosa di più di una semplice disciplina
tecnico-artistica.
Non è un
caso che l'avventura del Superstudio si concluda con una frase emblematica l'unica
architettura sarà la
nostra vita, perchè è proprio
la vita dei suoi protagonisti ad essere in quello che resta la cosa più
importante, la traccia di una passione, di una dedizione costante al racconto
dell'architettura.
Rappresentazione dunque e critica del sistema si fondono in un
pensiero coerente che consacra prima la loro Radicalità per poi storicizzarla, rendendo il loro lavoro
oggi ancora attuale e ricco di contenuti progettuali. I Superstudio grazie a
questo libro di Mastrigli, e alla sistematizzazione di tutta la loro produzione
raccolta in un volume di prossima pubblicazione ci permettono di ripercorrere
il loro progetto di vita, la loro architettura, fornendoci gli strumenti per
continuare a progettare il mondo in cui viviamo.
Come nell'istallazione La
moglie di Lot della biennale del
1978 è chiaro che l’architettura
sta al tempo come il sale sta all’acqua. L’architettura è
solubile nel tempo come il sale è
solubile nell’acqua.
In questa metafora che
agisce su livelli diversi il progetto
rafforza il suo significato, riuscendo allo stesso tempo ad essere
presente allo scandire del tempo e ad annunciare che molte delle utopie di
quegli anni avevano raggiunto un punto in cui il reale avrebbe preso il
sopravvento sulla potenza delle idee, che il tempo non avrebbe cancellato.
Prova evidente la perfetta attualità di quest’istallazione a distanza di anni come se tutte le
domande non potessero avere una risposta oppure che le risposte fossero tutte lì, nel recupero e nella coscienza
della propria capacità progettuale rimasta intatta allo scorrere del
tempo.
Mastrigli c'è lo
racconta nel modo migliore guidando in punta di piedi le tre interviste, che
lavorano su un doppio piano, da una parte creano il contesto e affrontano le
stesse tematiche attraverso uno sguardo soggettivo, da un'altra scavano nei
significati del loro lavoro guardandolo con distanza e trattandolo in modo
oggettivo, come un modello di ricerca.
I tre protagonisti di questo racconto, analizzano il proprio
lavoro alla luce della propria esperienza all’interno del gruppo, dimostrano
come i progetti si siano formati seguendo le loro singole personalità,
attraverso un continuo dialogo e scontro, ognuno aggiungendo un piccolo pezzo
in più alla storia
raccontata dall'altro.
Ecco alcuni frammenti direttamente dalle loro voci per darvi solo l'idea di questo libro.
Adolfo Natalini:
Non esisteva alcuna conciliazione: come in tutti i gruppi,
anche noi avevamo interessi diversi, alcuni di-vergenti o addirittura contrastanti.
Nel Superstudio avevamo una specie di ‘disturbo bipolare della perso-nalità', per cui ci appassionavamo ad un argomento e al
suo esatto opposto. Ad esempio, inizialmente nel Superstudio c'era un interesse
per la simbologia e la tecnologia e il Monumento Continuo nacque proprio dalla
sovrapposizione di queste due idee. L'artificio retorico che usavamo era
l'utopia nega-tiva, che consisteva nello sviluppare un modello ra-zionale sino
alle sue estreme conseguenze al fine di dimostrare la sua più
assoluta insensatezza. In questo modo volevamo criticare la fiducia cieca e
totale che veniva riposta sia nella rappresentazione monumentale sia nella
tecnologia. Negli anni ‘60 ancora non esisteva il termine «hi-tech»,
per cui Cristiano e io – in un sag-gio pubblicato su Necropoli
nel 1969 – ci inventammo la definizione «tecnomorfismo», con cui indicavamo un'architettura fatta a
immagine della tecnica.
Cristiano
Toraldo d Francia:
Grazie a mio padre, arrivavano a Bellosguardo ri-viste come
Scientific American che in Italia ancora non avevano una pubblicazione
corrispondente. Su questa rivista c'erano disegni formidabili, assono-metrie di
macchine spaziali e dei primi elaboratori che venivano usati dall'esercito
americano, l'Arpa-net. Fu così
che io e Adolfo – entrambi
molto in-teressati al mondo della tecnologia – riuscimmo ad avere dei riferimenti concreti e
precisi. Dalle pagine di Scientific American, ad esempio, avevamo visto e
studiato tutto il tema dell'Architettura interplaneta-ria, intesa come struttura
protettiva per l'uomo che sbarcava sulla luna: dalle varie ipotesi di
navicella, ai materiali con i quali erano fatti i vestiti degli astro-nauti.
Eravamo affascinati dal potenziale di questa protezione che ti permetteva di
sopravvivere in un ambiente –
del tutto ostile dal punto di vista climati-co – semplicemente attraverso un
abito, progettato come un' architettura da indossare. Ci recammo
all'Osservatorio Astrofisico di Arce-tri, di cui conoscevo il direttore,
Guglielmo Righini che ci permise di fare diverse visite e osservazioni,
testimoniate da molte fotografie con noi intenti a manovrare un radiotelescopio
e un telescopio lunare. Soprattutto convincemmo gli astronomi a calcolare che
tipi di forze sarebbero state necessarie per forma-re dei campi gravitazionali
tali che potessero reggere un'autostrada dalla terra alla luna e altre
costruzio-ni interplanetarie. Loro impostarono delle equazioni i cui numeri
ovviamente erano irraggiungibili, ma misurabili dunque ‘possibili'. Ci incuriosiva molto
l'idea di costruire vari campi gravitazionali che fa-vorissero l'insediamento
sulla luna, su altri pianeti e sul collegamento fra questi e la terra; eravamo
molto colpiti da questo salto di scala, dalla smitizzazione di questa grande
retorica della luna: «Siamo arrivati sul-la luna!» purtroppo non significava
niente perché nel
frattempo la terra stava diventando sempre più pove-ra, sempre più piccola, ed i conflitti sempre più acuti. D'altronde non si può dimenticare un'ultima
fa-scinazione dell'allunaggio –
decisamente politica –
per cui lo sbarco nel pianeta rappresentava l'occu-pazione dell'unico spazio rimasto
fuori dalla logica della merce, dalla logica del sistema. Per questo, dal
nostro punto di vista, valeva la pena fare delle archi-tetture che partissero
da questo passo dell'uomo sul-la luna, ma che fossero qualcosa di più, che portasse-ro a dei veri e
propri ‘sommovimenti
interplanetari'.
Piero Frassinelli:
Sin da piccolo mi interessavo di arte e cominciai a
raccogliere ritagli da giornali e riviste ma quando de-cisi di ordinare il
materiale, creando una scheda per ogni opera – su fogli di carta
da pacchi per risparmia-re – cominciai a integrare le schede con
brani di libri e voci di enciclopedie; l'unico criterio catalogatorio era
l'ordine rigorosamente cronologico delle opere.
Ne usciva fuori qualcosa in cui le culture più
diverse erano affiancate in maniera quasi indif-ferente.
«L'uomo è
la casa dell'uomo»: in questa frase
io ho sempre creduto. Il Duomo di Modena e un tem-pio Hoysala stavano l'uno
affianco all'altro perché per me erano esattamente lo stesso,
anzi preferivo le sculture di Belur a quelle di Wiligelmo; già allora mi resi conto della stupidità ideologica che voleva l'arte occidentale superiore per definizione
a quella delle altre culture.
in questo senso, l'idea stessa di Monumento Con-tinuo –
di architettura che abbracciava la terra nella sua interezza ... La moglie di
Lot rifletteva la mia idea di mutamento, di ‘impermanenza'
direi, per cui l'architettura ha una nascita istituzionale seguita da una vita
che istituzionale non è affatto; l'idea dell'obsolescenza,
dell'entropia in architettura, mi ha sempre affascinato, essendomi sem-pre
interessato anche di archeologia (altra branca delle ‘scienze
umane') che, più di ogni altra attività dell'uo-mo, esprime il Sic transit
gloria mundi. A questo pensiero si riconduce anche la mia riflessione sull'‘anti-monu-mentalismo',
secondo cui nell'architettura esistono so-lamente due committenti: l'uomo e il
potere, ciascuno dei quali nega per definizione l'altro.
Piero Frassinelli